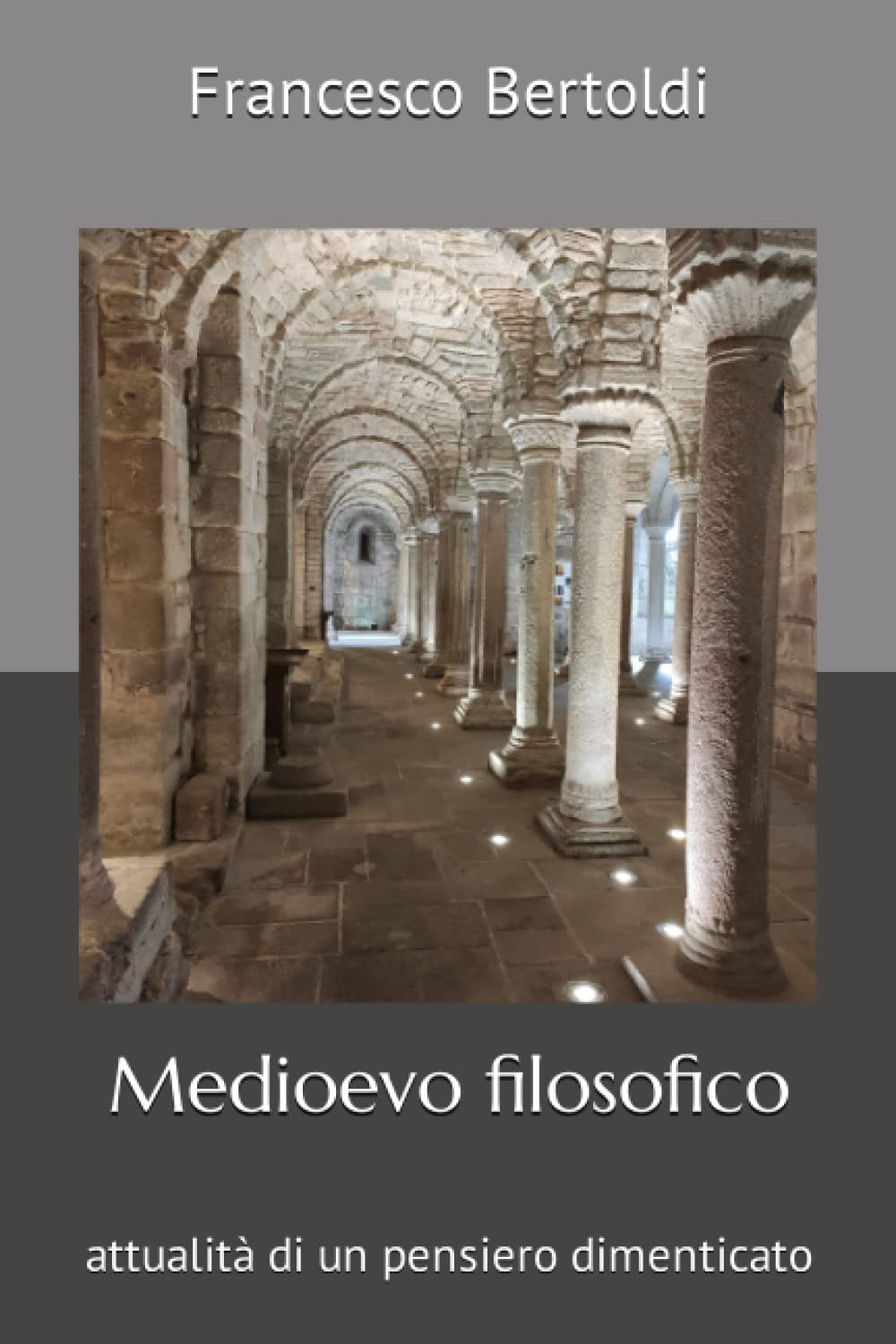
Medioevo filosofico: le prove di Dio
l'esistenza di Dio
Dio! Dio! Dio! Se lo vedessi! Se lo sentissi! Dov’è questo Dio?
«Per una filosofia come quella del Medioevo tutto si riannoda e si riassume in Dio, che è centro e significato non di un particolare livello della realtà, quello spirituale, il “bisogno religioso”, ma della realtà tutta. «Chi è Dio?» è una domanda che Tommaso d’Aquino, secondo quanto riferiscono i suoi biografi, era solito fare da bambino ai monaci di Montecassino, dove ricevette la sua educazione. «Dio! Dio! Dio! Se lo vedessi! Se lo sentissi! Dov’è questo Dio?» chiedeva l’Innominato al cardinal Federigo48. Noi non vediamo Dio, il Mistero che fa tutte le cose, eppure sapere se Egli esiste o se tutto finisce con ciò che immediatamente vediamo e tocchiamo, mi pare sia la questione fondamentale che la ragione si può porre, perché dalla risposta che le diamo dipende la questione se la vita abbia o no un senso, un senso che a noi tocchi solo riconoscere e accettare. Una risposta negativa infatti (Dio non esiste) implicherebbe che non ci sia alcun senso oggettivo nella realtà e allora tutto dipenderebbe da come noi riusciamo a crearne uno, sapendo che comunque con la morte finisce tutto.
Sua esistenza
1. Importanza della dimostrazione razionale. È convinzione comune presso tutti i filosofi medioevali che la ragione umana possa argomentare in modo certo l’esistenza di un Essere Infinito e Creatore, quello stesso Dio che si è rivelato in Cristo. Diversa però è l’importanza attribuita a tale argomentazione razionale. Alcuni pensatori medioevali hanno infatti dedicato uno sforzo piuttosto ridotto alla dimostrazione dell’esistenza di Dio: in quanto la certezza della Sua esistenza sembrava dipendere più da una buona volontà che da una capacità razionale, più dall’apertura del cuore che dall’argomentare dell’intelletto. Lo stesso Gesù aveva detto che Dio non è accessibile (tanto) ai «sapienti e ai dotti», ma si rivela ai «piccoli» e agli umili di cuore. In questa linea troviamo ad esempio un Agostino o un Bonaventura, che dedicano uno spazio esiguo ad una rigorizzazione “tecnica” della prove dell’esistenza di Dio. Citiamo ad esempio il seguente passo dalla questione De Mysterio Trinitatis, di Bonaventura: «se esiste un ente che dipende da un altro, esiste anche l’ente che non dipende da un altro. Perché nulla può far passare se stesso dal non essere all’essere; dunque, è necessario che vi sia una prima ragion d’essere che è nell’ente primo, il quale non è stato prodotto da un altro. Se dunque l’ente che dipende da un altro è detto ente creato e l’ente che non dipende da un altro è detto ente increato ed è Dio, tutti i diversi tipi di ente implicano l’esistenza di Dio»49. Per avere un’idea più completa di quanto vogliamo dire si può comunque leggere tutto l’articolo, in cui il Serafico parla della indubitabilità dell’esistenza di Dio.
Uno sforzo ben maggiore troviamo invece in pensatori come Duns Scoto e Tommaso d'Aquino. Tali filosofi si adoperano per non lasciare niente, o almeno il meno possibile, di implicito e di oscuro, e per non saltare alcun passaggio logico, e costruire una dimostrazione serrata e rigorosa. Non che tali pensatori ignorassero la verità evangelica, citata poco sopra, sulla importanza della semplicità di cuore, ma essi tenevano anche presente che una cosa è la Rivelazione soprannaturale che Dio fa di Sé in modo gratuito e imperscrutabile, raggiungendo solo alcuni esseri umani, altra cosa è la conoscenza di un Creatore che la ragione di qualsiasi uomo può e deve raggiungere come base prima della sua eticità fondamentale. Anche in questo caso i due aspetti si integrano piuttosto che escludersi: da un lato nessuno nega che la dimostrazione debba essere il più possibile stringente e persuasiva, dall’altro nessuno si illude che basti una prova puramente razionale per condurre un uomo alla fede nel Dio di Gesù Cristo. Dunque, né disprezzo per la ragione, né sua sopravvalutazione: e, all’interno di tali argini, diverse sfumature.
La linea di relativizzazione della ragione, se portata agli estremi, per cui nella vita uno dovrebbe affidarsi a una “pura” fede, implicherebbe il rischio del fanatismo: il che può comportare ad esempio arroccamento testardo in posizioni acriticamente assunte, con le conseguenze pratiche di una indisponibilità a dialogare con altre posizioni umane, e, spesso, anche ad ammettere i propri torti.
D’altra parte un affidarsi come a criterio ultimo alla ragione (“credo in Dio solo nella misura in cui lo capisco perfettamente”, piuttosto che “aderisco al modo storico e concreto con cui Lui si è manifestato”) porterebbe a rischi non meno gravi: una orgogliosa quanto asfittica fissazione nei propri pensieri, con possibili esiti come un impallidente sganciamento dalla carnalità della vita, e magari una facilità a criticare in modo velenoso, o sarcastico, gli errori di chi è più coinvolto con «la gloria incerta dell’ora positiva» (Eliot).
Certo, la stessa divaricazione medioevale tra quelle che comunque restano due diverse sottolineature, dimostra come il problema della composizione tra i due aspetti sia tutt’altro che facile. Se ne dovrebbe trarre, credo, l’indicazione per un’umile e decisa ricerca della totalità, in cui solo sta la verità.
[...]
Le prove a posteriori: le “cinque vie” di Tommaso
Le prove, o dimostrazioni, “a posteriori” sono quelle che partono dal mondo sensibile, il mondo materiale, “esterno”. Tra tutte le prove a posteriori elaborate dai filosofi medioevali, le “cinque vie” di Tommaso spiccano in modo particolare come le più famose e le più chiare (quelle elaborate da Duns Scoto ad esempio hanno senza dubbio una complessità maggiore). Mi limiterò perciò a esporre quelle.
Anzitutto riassumo la struttura, generale e comune, di tali prove, e lo faccio usando una terminologia che non è sempre fedele alla lettera del Dottore Angelico:
1a. Il dato primo e immediato della nostra conoscenza non è l’Infinito, ma il finito, anzi il finito sensibile.
Noi cioè non conosciamo immediatamente, “subito”, Dio, che è l’Infinito: Dio è invisibile. La prima realtà che noi conosciamo è la realtà visibile, sono le cose materiali: le persone umane, le case, gli oggetti, gli animali, le piante, insomma il mondo.
1b. È però possibile, proprio a partire dal finito, risalire all’Infinito, cioè a Dio.
Infatti dato che il finito, e in particolare il mondo sensibile, è creato da Dio, dall’Infinito, non è possibile che non ci dica qualcosa di Chi lo ha creato, non può essere qualcosa di totalmente estraneo al suo Creatore.
2. Il finito presenta una sorta di ambivalenza, o meglio una polarità, che implica il riferimento ad un terzo Termine, superiore ai due poli.
2a. Da un lato infatti il finito si presenta come governato da certe leggi della realtà, i primi principi (o principi supremi) dell’essere, ossia il principio di non contraddizione e quello di identità, per i quali l’essere deve essere, incondizionatamente. In termini meno tecnici e più immaginifici: nel finito c'è della luce, c'è un riverbero di assoluto. Esistenzialmente questo significa che il mondo ci si presenta come bello, armonioso, buono. Che è quanto dire che, almeno per certi aspetti, la vita è fonte di gioia. Lo prova il fatto che noi le siamo attaccati, desideriamo vivere e temiamo di morire: perché vivere è percepito come un bene.
2b. D’altro lato, tuttavia, il finito sembra contraddire tali leggi, tali principi: da un punto di vista metafisico il divenire (il cambiamento) sembra smentire continuamente il principio di non contraddizione, mostrando la fragilità del finito, la sua non-assolutezza, la sua relatività. Riprendendo la metafora di prima: la luce che nel finito è presente è limitata da ombre. Esistenzialmente questo significa che nel mondo c’è il male, c’è la morte. E la vita, oltre al riso e alla gioia, è intessuta anche di tristezza e di motivi di pianto.
2c. Insomma nel finito da un lato c’è della perfezione, d’altro lato c’è della imperfezione: segno che la perfezione che è nel finito non è a casa propria, ma è ospite. Ossia, in termini più tecnici, segno che la perfezione non è sussistente, ma partecipata. Il finito, cioè, ha della perfezione, ma non è tale perfezione: ma se la perfezione che lo permea (e che si esprime nelle leggi supreme dell’essere) non è sua, bensì è ricevuta, allora sarà ricevuta da altro, sarà di altro, di una Realtà assolutamente perfetta, cioè Dio.»
🛒 ricerche / acquisti
cerca libri su Amazon sul tema: fede rapporto fede/ragione esistenza di Dio S.Anselmo prove a-priori prove a posteriori Tommaso d'Aquino Bonaventura Duns Scoto creazione provvidenza anima/corpo immortalità immortalità dell'anima società giusta giustizia filosofia islam civiltà storia classici esami esame di stato tesina tesi ricerca cultura libri on-line Medioevo filosofico: le prove di Dio .